

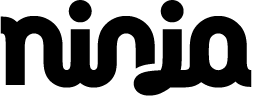
Diventa free member
Vuoi leggere questo articolo e le altre notizie e approfondimenti su Ninja? Allora registrati e diventa un membro free. Riceverai Breaking News, Marketing Insight, Podcast, Tips&Tricks e tanto altro. Che aspetti? Tieniti aggiornato con Ninja.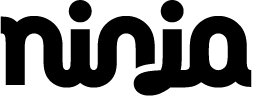
Diventa free member
Vuoi leggere questo articolo, le altre notizie e approfondimenti su Ninja? Allora lascia semplicemente nome e mail e diventa un membro free. Riceverai Breaking News, Marketing Insight, Podcast, Tips&Tricks e tanto altro. Che aspetti? Tieniti aggiornato con Ninja.
Due cose mi spingono a scrivere questo editoriale: la prima, il senso di fastidio di default che provo quando vedo un’iniziativa di brand communication contagiare le persone esclusivamente per immeritata moda. La seconda, aver trovato questo articolo di Ben Terrett di RIG London che mi fa sentire meno sola, tra i commenti degli ipnotizzati dalla grafica, in questo fastidio.
Molti di voi avranno già provato l’applicazione Intel – Museum of Me. In poche parole (quelle che si merita) accedendo col proprio account Facebook, un algoritmo Intel aggrega i vostri dati - status, amici, post commentati, foto liked - e ne tira fuori un museo virtuale, una sorta di gallery artistica sulla vostra vita.
Alla fine, l’idea è la stessa di altre iniziativa di cui vi abbiamo parlato di recente (Memolane, The Hero e, sforando anche nel mondo analogico, Social Memories). A cambiare è solo la salsa, sono sempre memorabilia, più o meno tangibili, del tuo ego sociale.
In questo mare di iniziative fac-simile di memory curation autogenerata e del loro impiego da parte dei brand, vorrei concentrarmi in particolare su Intel. Non mi sarà facile, complice una della musiche più inquietanti che abbia mai sentito, proprio quella di sottofondo che hanno deciso di usare in Museum of Me.
Ho letto diverse definizioni di questa campagna: brillante, simpatica, coinvolgente. Credo invece che il risultato di quest’applicazione sia al contempo sorprendente e raccapricciante. Perché? Perché affidare ad una macchina il compito di raccontare una storia su di te è estremamente rischioso. E per un pubblicitario che vuole comunicare l’intelligenza di una macchina, creare una macchina potenzialmente stupida è a dir poco un boomerang incoerente.
Tanto per cominciare, è stupido pensare che tanti commenti equivalgano ad un’amicizia, o che un tag in una foto possa realmente accomunare due persone lontane.
Una persona in questa foto è una cara amica che ho incontrato un mese fa, ma che non vedevo da anni. Altre due (in realtà Intel ha troncato la foto nell’upload su Facebook) sono mie tesiste.
Sono nata a Santa Ana, ma non quella nel Sudest asiatico.
Non so perché sia importante sapere che la parola che più si ripete sul mio wall è una preposizione articolata.
Onestamente, qui non vedo nemmeno di che si tratti. Non riconosco.
L’immagine di braccia meccaniche che agitano le foto dei miei amici è un’ossimoro schizofrenico quasi quanto Nivea che cerca di raccontare una tradizione secolare di intimità mentre in sottofondo Rihanna canta di lontananza:
“So how come when I reach out my fingers
It seems like more than distance between us”
Ma torniamo ad Intel e concludiamo. Il claim finale è Visualize yourself. Visibly Smart.
Tutto qui? Peccato che l’esecuzione sia visibilmente stupida.
Siamo tutti egocentrici (chi dice il contrario, mente) ma smettiamo di esserlo se qualcuno o un’azienda ce lo fa notare in maniera così incongruente. Con uno stile di engagement comico più che altro. Intel, non puoi togliere agli umani la prerogativa di essere storyteller e narratori autentici di se stessi. Se pensi di sostituirti in maniera intelligente ai nostri veri ricordi con la promessa di solleticare il nostro ego, non basta. E se poi lo solletichi random e in maniera paradossale, senza creare alcuna connessione di valore col tuo brand, ancora peggio.