

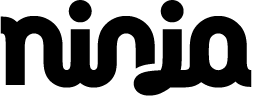
Diventa free member
Vuoi leggere questo articolo e le altre notizie e approfondimenti su Ninja? Allora registrati e diventa un membro free. Riceverai Breaking News, Marketing Insight, Podcast, Tips&Tricks e tanto altro. Che aspetti? Tieniti aggiornato con Ninja.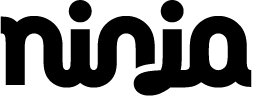
Diventa free member
Vuoi leggere questo articolo, le altre notizie e approfondimenti su Ninja? Allora lascia semplicemente nome e mail e diventa un membro free. Riceverai Breaking News, Marketing Insight, Podcast, Tips&Tricks e tanto altro. Che aspetti? Tieniti aggiornato con Ninja.
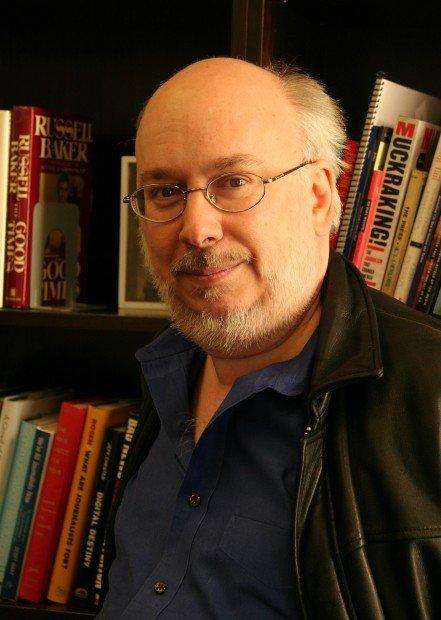
Ninja Marketing ha incontrato il professor Jenkins a seguito del suo speech al Centre Pompidou di Parigi. Ecco a voi l'intervista in esclusiva!
Se mai c'è stato un qualcosa chiamato "web tribe", e la cosa è altamente discutibile, il mondo online si è diversificato al punto oggi in cui sarebbe inutile parlarne come se esistesse solo un gruppo di "persone" o un set di attività. Usiamo il web per fare molteplici cose, come individui, come network e come comunità, alcune di queste cose le facevamo da prima che il web esistesse, alcune le facciamo perché esiste il web, ed alcune le facciamo anche se il web ci rende più difficile farle.
Credo dobbiamo spostarci dalle generalizzazioni semplici su cosa la web culture sia e sviluppare un linguaggio più descrittivo che guardi a che cosa succede su siti specifici, su come pratiche particolari siano impiegate da comunità particolari attraverso piattaforme particolari.
La cultura partecipativa descrive cosa succede quando ampliamo il numero di persone che hanno accesso ai mezzi di produzione e diffusione culturale. Il nostro attuale momento di cultura partecipativa emerge da svariate centinaia di anni di lotte da parte di tanti gruppi diversi per espandere la capacità comunicativa di persone normali e comunità grassroots, spesso contro l'espansione del potere di broadcasting dei corporate media. Stiamo raggiungendo il punto in cui la cultura partecipativa è una forza di cui tenere conto nelle decisioni fatte dai governi e dalle aziende. E dovunque il pubblico eserciti il suo potere di produrre e far circolare messaggi in modi che stiano aiutando a diversificare e democratizzare l'agenda culturale.
Avendo detto ciò, possiamo solo parlare del movimento verso una cultura sempre più paretecipativa: molte persone ancora hanno difficoltà con l'accesso limitato alla tecnologia (il digital divide) ed alle competenze ed esperienze necessarie per participare significativamente (il participation gap). Quindi, guardando al momento presente, le lotte principali riguardano il chi riesce a partecipare ed in quali termini.
E' adesso molto più chiaro che il Web 2.0 e la cultura partecipativa non sono la stessa cosa: che non possiamo semplicemente annullare i desideri contraddittori di aziende e consumatori, per esempio, ma piuttosto dobbiamo confrontare i diversi interessi e le diverse agende che ciascuno di loro apporta ad ogni data transazione. Gli ultimi anni ci hanno mostrato continui dibattiti su termini di servizio -- problematiche legate alla privacy, al copyright, alla censura, al data mining ed al branding, preoccupazioni sulla network neutrality, e su altri temi relativi alla possibilità per le nostre relazioni ed informazioni di essere mutuate da una piattaforma all'altra, ed ognuna di queste lotte ha implicazioni enormi per il futuro della cultura partecipativa.
Il mio prossimo libro, Spreadable Media (scritto con Sam Ford e Joshua Green) si incentra sulle tematiche di diffusione. Facciamo una distinzione principale tra distribuzione (la diffusione di content attraverso canali ben consolidati e controllati a livello corporate) e circolazione (il sistema emergente in cui comunità grassroots ed individui giocano un ruolo molto più attivo nella diffusione del content, spesso attraverso mezzi non autorizzati). Tali pratiche di networking esercitano un impatto molto più grande in termini di quali forme di culture catturino l'attenzione o che cosa costituisca i termini principali dei nostri dibattiti politici, in modi che metteranno ulteriormente in questione l'influenza dei mass media sulla nostra vita.
La parola transmedia, di per sé, si riferisce a qualsiasi insieme di relazioni che si dispieghi attraverso molteplici piattaforme media. La prima ondata di interesse sul transmedia si è concentrata sullo storytelling e sul branding, specialmente sulla complessa interazione tra questi due elementi in un'industria concentrata sempre di più su esperienze di branded entertainment. Sempre di più, sono interessato ad altre tipologie di relazioni transmediali -- specialmente in modi in cui le logiche e le pratiche transmediali sono adottate da educatori, attivisti, oppure gruppi non profit, NGO, chiese...
Quindi, ad un certo livello, c'è ancora molto lavoro interessante fatto da storyteller commerciali e professionali, che intendono usare molteplici piattaforme media per espandere ed approfondire le storie che possono raccontare e permettere ai fan di essere coinvolti con modalità più intense nei riguardi delle storie di loro interesse. Dall'altro lato, vediamo altri gruppi adottare pratiche transmedia in modi che non sono necessariamente motivati da proeccupazioni commerciali e possono renderle strumenti per costruire un mondo migliore.
Abbiamo costituito un gruppo di ricerca all'Annenberg Innovaction Lab che sta esplorando molte di queste dimensioni del transmedia. Il nostro progetto, Flotsam, che stiamo realizzando in collaborazione con The Alchemists, utilizza il gioco transmediale come un veicolo per enfatizzare l'apprendimento, creando una serie di esperienze intorno ad un premiato libro per bambini e che crei un ponte tra fiction e realtà, che incoraggi le interazioni cross-generazionali.
[yframe url='http://www.youtube.com/watch?v=azepxJlktL4&feature=plcp']
Gli Americani hanno fatto distinzione tra la scuola dell'East Coast e quella della West Coast per quanto riguarda il transmedia. La East Coast school è più incentrata sui giochi, spesso più indipendente, e spesso implica la creazione di un'esperienza di networking come un ARG, che fin dall'inizio include materiali creati e disseminati attraverso molteplici piattaforme media. La West Coast School è più guidata da Hollywood, tende ad incentrarsi sulla creazione di nuove estensioni per una "maternità" (un testo di base televisivo o filmico) ed è plasmata fortemente dalla logica di costruzione di un franchise.
Potremmo adesso aggiungere, a queste distinzioni, altre due: una emergente in Europa, dove la produzione transmediale è strettamente collegata e vecchie tradizioni del servizio pubblico televisivo e la produzione di cinema nazionale, quindi è molto più idoneo di entrambi i modelli americani ad essere legato ad ambizioni educative, pubbliche ed artistiche. La tradizione latino-americana, che si sta ancora formando, sembra più strettamente legata da un lato alle tradizioni della telenovela e dall'altro alle tradizioni della cultura folk, come il carnevale.
Non sono sicuro di saperne già abbastanza per sottolineare le differenze in queste quattro scuole di produzione transmediale, ma è chiaro che il risultato è la predominanza di diversi valori ed obiettivi di base, diversi modelli per come le parti interagiscono tra loro, assunti diversi su come l'audience interagirà con il contenuto, e diversi modelli di business e flussi di finanziamento.
E ovviamente, in ogni caso, ci sono eccezioni a questi modelli. In Europa, per esempio, vediamo degli spostamenti dal finanziamento pubblico per le industrie creative a causa della crisi economica, un aumento di privatizzazioni nella cultura produttiva, cosa che è destinata ad avere conseguenze in termini di quali tipo di agenda motivino la produzione transmediale. E in America Latina, ci si sposta lontano da un esclusivo focus sul mercato nazionale per aumentare le aspirazioni di divenire un media player globale, specialmente in Brasile. In entrambi i casi, questi trend possono spingere i media producer verso qualcosa di più vicino al modello della West Coast, ma sospetto che vedremo ancora una combinazione ibrida di queste due cose nell'immediato futuro.
Non sono sicuro che ciò che facciamo online sia radicalmente differente da cosa facciamo offline, in questi termini. Tutto il giorno prendiamo delle decisioni, alcune delle quali sono altamente individualizzate (e dunque sono motivate in parte dal nostro desiderio di differenziarci da chi è intorno a noi) ed alcune emergono dalle nostre forti affiliazioni con gli altri (e sono motivate dal desiderio di socializzare).
Consumiamo media come fan (sia in termini di investimento appassionato e di forte attaccamento sociale con gli altri) ma a molto di esso ci relazioniamo in una modalità molto più casual e personalizzata. Alcuni brand creano comunità forti, ma molti altri li corteggiano e competono per loro attraverso tipi tradizionali di comunità, e la maggior parte finiscono per attrarre consumatori individuali.
Quindi, credo che concetti come comunità di fan e di brand abbiano valore nell'aiutarci a comprendere alcuni tipi di fenomeni, ma sono divenuti così seduttivi per un periodo di tempo che specialmente nell'industria dei media, si è giunti all'assunto per cui ogni brand voleva trasformare i propri consumatori in partecipanti all'interno di una comunità di marca. Ed è qualcosa che semplicemente non succederà. La maggior parte dei consumatori non si interessa alla maggior parte dei brand in questo modo. Questo non vuol dire che il consumo di network non sia un fattore potenziale nella vita di un brand, ma occorre riconoscere che queste comunità hanno la propria esistenza, le proprie storie, valori, e tutto ciò che entra nel proprio spazio deve entrare alle loro condizioni.
Ne parliamo molto in Spreadable Media. Gli individui ed i gruppi possono aiutare a far circolare messaggi di brand attraverso i loro network, ma più spesso lo fanno perché il brand diventa una risorsa che permette loro di apportare un contributo significativo al dibattito continuo della comunità, perché permette loro di contribuire alle interazioni sociali per loro rilevanti, perchè permette loro di dare qualcosa alle persone loro care, e non perché sono esageratamente interessati al messaggio del brand o alla sopravvivenza economica del brand che l'ha prodotto.
Quindi, vorrei dire che le aziende devono comprendere le dinamice sociali delle networked communities ma non devono necessariamente immaginarle come centrate intorno agli obiettivi ed interessi dell'azienda. Come suggerirebbe il mio collaboratore, Sam Ford, questo processo inizia ascoltando attivamente ai consumatori piuttosto che semplicemente raccogliendo dati che confermino le proprie ipotesi già esistenti o utilizzando le community semplicemente come un veicolo per diffondere il proprio messaggio.
[Ringrazio Mirko Pallera, Alex Giordano ed Antonio Prigiobbo per aver partecipato al pool delle domande!]
[nggallery id=31]