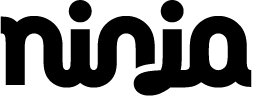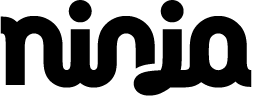Beh! La prima ipotesi potrebbe essere di un clamoroso schiaffo morale; la seconda, invece, potrebbe rappresentare la possibilità di una collaborazione o meglio di una rinnovata attenzione verso chi non ha le stesse fortune.
È questa l’idea alla base dello spot di bonsaininja per make a change. Ma cos’è questo “make a change” e perché questo spot?
Nel manifesto e nelle intenzioni degli organizzatori – tra cui Andrea Rapaccini, manager affermato – vi è la volontà di costruire un osservatorio capace di mettere in rete le varie aziende che, in qualche modo, vogliono cominciare ad intraprendere la strada di un business sociale e sostenibile all’interno sia delle aree aziendali già esistenti, sia rispetto ad aziende autonome costruite ex novo.
Fondamentale, dunque, è la volontà di portare avanti un nuovo modello di fare impresa – un’impresa sociale appunto – già presente in altri paese – ad esempio le Community Interest inglesi – e regolata, in Italia, dalla legge 118/2005.
Un cambiamento in grado di ritrovare un’umanità anche tra la folta schiera dei business man e delle aziende, che vada al di là della cartina di tornasole spesso delineata dalla responsabilità sociale d’impresa.
Un valore aggiunto in un mercato che fa della produttività l’unico mito senza pensare alle conseguenze sociali che molto spesso genera e che restano, come tutte le controindicazioni, al palo dell’emarginazione.
Scambiare prodotti e servizi in grado di creare un valore sociale economicamente sostenibile è l’obiettivo di tutta la filosofia di make a change:
“Un movimento che vuole cambiare il sistema da dentro il sistema. Vuole affiancare al business tradizionale un nuovo asset class per gli investimenti responsabili: il business sociale, dove il denaro è considerato uno strumento funzionale a produrre ricchezza per la comunità. Questa tipologia di investimenti è definita anche come “investments for social and environmental impact”, e la sua performance è valutata in base all’impatto prodotto sulla società e sull’ambiente e non in base al ritorno economico.”
Tutto ciò è possibile? Non si potrebbe verificare l’ipotesi che imprese nate in questo senso si rivolgano, poi, alla mera massimizzazione del profitto? C’è un modo per mantenere ben saldo il risvolto sociale della mission aziendale? La risposta che si danno a “make a change” verte sul rispetto dei paramentri di legge, sulla forza di una mission blindata e sul controllo esterno da parte di persone non implicate nell’azienda stessa.
Non è possibile sapere se questa nuova via/approccio che si tenta di tracciare sia giusta o sbagliata, né tanto meno si può facilmente sospendere il giudizio comune sulle imprese, pensando che d’ora in poi saranno buone, generose e caritatevoli.
Credo però che sia importante assistere alla nascita di discussioni concrete intorno al valore sociale di un’impresa, (vedi anche il concetto di societing) più che alla sola capacità di remunerare i pochi azionisti; di sostenere e controllare i progetti che tendono ad integrare l’interesse della collettività con quello del capitale.
Le alternative, a mio avviso, nascono se intorno c’è la capacità di concepire un bisogno e di portarlo all’attenzione, perché se proprio si vuol parlare di sociale allora non possiamo prescindere dalla consapevolezza dell’esistenza di un bene comune declinabile in vari aspetti – sociale, ambientale, politico – che necessita di essere costantemente curato.