

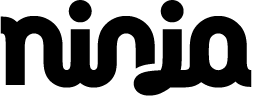
Diventa free member
Vuoi leggere questo articolo e le altre notizie e approfondimenti su Ninja? Allora registrati e diventa un membro free. Riceverai Breaking News, Marketing Insight, Podcast, Tips&Tricks e tanto altro. Che aspetti? Tieniti aggiornato con Ninja.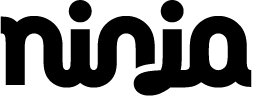
Diventa free member
Vuoi leggere questo articolo, le altre notizie e approfondimenti su Ninja? Allora lascia semplicemente nome e mail e diventa un membro free. Riceverai Breaking News, Marketing Insight, Podcast, Tips&Tricks e tanto altro. Che aspetti? Tieniti aggiornato con Ninja.
Philip K. Dick nel racconto che ha ispirato il film Minority Report di Spielberg, si inventò i poteri di premonizione dei Precog, tre persone con la capacità di sognare i crimini che sarebbero stati commessi nel futuro. Nel racconto una divisione speciale della polizia, la precrimine, utilizza i loro poteri per arrestare i criminali potenziali, rei di avere l'intenzione di commettere un crimine.
Da qualche anno alcuni dipartimenti di polizia americani, come quello Los Angeles che lo fa dal 2012, usano tecniche basate su particolari algoritmi e l'analisi dei dati per ottimizzare la presenza delle pattuglie sul territorio: il software sviluppato dalla Predpol e messo a loro disposizione permette infatti di creare delle mappe in cui viene visualizzata la probabilità che vengano commessi dei crimini: come le mappe termiche, la maggiore intensità indica una maggiore probabilità di attività criminali, e perciò l'opportunità di inviare le pattuglie. Secondo le loro dichiarazioni con queste tecniche in alcuni casi sono riusciti a ridurre la percentuale di crimini commessi di un 20%.
Predpol e Palantir non sono le uniche imprese private che propongono queste tecnologie: anche Hitachi ha pochi giorni fa annunciato di poter iniziare i test della loro tecnologia predittiva in alcune città americane. A differenza di altri sistemi, quello proposto da Hitachi utilizza il machine learning e i dati dei social, i tweet in particolare, per accrescere di un 15% l'accuratezza delle loro previsioni.
Tranne quello della Hiyachi, questi software e tecniche però non fanno uso dei dati presenti sui social, ma di quelli presenti nei database delle forze dell'ordine: si tratta quindi di analisi statistiche che non hanno impatto ne implicazioni sulla privacy, trattandosi di dati aggregati.
All'università della California hanno però creato l'istituto delle tecnologie predittive (UC Institute for Prediction Technology) che ha proprio come missione lo sviluppo e lo studio di tecnologie predittive del comportamento umano, sfruttando i dati presenti sui social network.
Fondato nel 2015 , l'istituto ha come aree di ricerca il tracciamento di comportamenti a rischio, per prevenire il diffondersi di malattie, la povertà (sic!) e il crimine, informando le autorità competenti. Altre aree di ricerca dichiarate sono l'individuazione dei fattori per predirre l'evolversi delle opinioni politiche, di valori sociali e morali, del successo accademico o del coinvolgimento della comunità e l'individuazione delle ragioni per cui le persone adottino certe tecnologie, comprino certi prodotti o seguano certe tendenze.
Queste tecnologie e idee sono le stesse che hanno ispirato le agenzie di spionaggio e controspionaggio ad attivare quel tipo di controllo e spionaggio di massa sfociato poi nel Datagate, grazie alle rivelazioni di Edward Snowden.
Nonostante in apparenza non siano una novità, il dibattito è stato rilanciato del New York Times di recente, interrogando alcuni esperti sull'efficacia e l'eticità di queste tecniche poliziesche di prevenzione del crimine.
Tra coloro che sollevano qualche obiezione e chiedono cautela nell'adozione di queste tecnologie c'è Andrew Papachristos, professore di sociologia e direttore del centro di ricerca per le disuguaglianze della università di Yale, che invita alla prudenza e ad una supervisione dell'uso di questi dati da parte delle forze di polizia, chiedendo anche trasparenza sui metodi usati dalle compagnie private che forniscono la tecnologia. "Un approccio basato sul delinquente e sul profitto potrò solo esacerbare un sistema giudiziario punitivo e far nascere paure su uno stato di polizia in stile Minority Report", afferma Andrew Papachristos.
Anche Faiza Patel, co-direttore del programma "Libertà e sicurezza nazionale" dell'università di New York, chiede cautela, nonostante l'entusiasmo che queste tecnologie possano destare, dichiarando : "la polizia predittiva non può diventare profilazione razziale con un diverso nome", riferendosi al fatto che le minoranze di colore e latine potrebbero essere più danneggiate e vulnerabili.
Persino l'ex-pubblico ministero federale Kami Chavis Simmons (ora professore alla facoltà di legge dell'università Wake Forest e direttore del programma di giustizia criminale) indica che "la tecnologia è cruciale per le forze dell'ordine, ma non è mai una panacea".
Dei sei esperti invitati a dibattere solo Sean Young, direttore del'istituto delle tecnologie predittive dell'Università della California, è apertamente e completamente entusiasta, e delegando ad altri lo studio delle implicazioni etiche relative all'uso di queste tecnologie, invita ad usarle in nome dell'innovazione e dei benefici per la comunità.
Ma sono davvero efficaci queste tecnologie? Nonostante la sorveglianza antiterrorismo e le leggi che riducono la privacy in favore di una maggiore sicurezza, sembrerebbe di no, dato che attentati come quello alla maratona di Boston nel 2013 e quelli recentissimi a Parigi o nel Mali non sono stati previsti.
In Gran Bretagna hanno creato nel 2013 il centro di ricerca "What Works - Crime reduction" (cosa funziona - riduzione del crimine), investiga e analizza quali siano le pratiche e interventi migliori per ridurre la criminalità.
Si preoccupano di capire le soluzioni anti-crimine in termini di costi, qualità, impatto, ragioni e contesti per cui funzionano e metodi di implementazione, producendo strumenti e guide per le forze dell'ordine.
Secondo una interessante tabella che chiamano "crime reduction toolkit" e in cui ogni tipo di intervento viene valutato in una scala che misura effetto sul crimine, meccanismo di funzionamento, contesto, implementazione e costi, il monitoraggio elettronico ha un modesto impatto nella riduzione del tasso di criminalità, minore addirittura di una tecnologia matura come le telecamere a circuito chiuso.
I crimini, secondo alcuni risultati delle ricerche del centro, sono in generale associati ad una piccola porzione di luoghi, vittime e delinquenti, perciò risulterebbero efficaci anche azioni di prevenzione attraverso l'educazione e la deterrenza (per esempio, e oltre alle già citate telecamere, una maggiore illuminazione stradale e le vigilanza di quartiere).
Sembrerebbe che, da entrambe le sponde dell'atlantico, non si metta in discussione l'efficacia tecnica del monitoraggio dei social media (anche se non è elevata) ma l'impatto sociale e la rilevanza etica.
La tesi più popolare è che in nome della sicurezza sia consigliabile e opportuno sacrificare la propria privacy (o meglio, riservatezza), sostenendo che chi non ha nulla da nascondere non abbia nulla da temere.
Ma c'è da considerare che l'erosione lenta e continua dei nostri diritti civili in nome della sicurezza può portare a conseguenze nefaste sia per gli individui che per la comunità.
Non è solo da temere la nascita di un grande fratello Orwelliano che tutto vede e controlla, ma anche e soprattutto la possibilità che si subiscano processi Kafkiani, in cui siamo condannati e penalizzati senza sapere perché.
Basta un falso positivo e, secondo le tecniche di analisi della rete, potreste vedervi negare l'ingresso ad un paese perché troppo vicini a qualcuno non gradito, oppure potreste non essere ammessi ad una scuola, università o lavoro perché, potenzialmente, siete... criminali?
Sono purtroppo molti e sempre più frequenti i casi in cui giornalisti, ma anche persone comuni sono fermati alla frontiera, in quella terra di nessuno che negli aeroporti è prima dei controlli, e sottoposti a estenuanti (e secondo alcuni, vessatori) interrogatori e perquisizioni.
I motivi? Spesso inconsistenti, come aver partecipato ad un matrimonio musulmano, per esempio. (https://thenib.com/crossing-the-line-e765bf8ca85a#.us08i0jea)
Le tecniche di analisi delle reti e dei social in particolare sembrano poter dare un contributo, anche se non sostanziale, alla lotta contro il crimine. Ma il prezzo da pagare ne vale davvero la pena?