

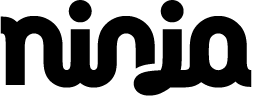
Diventa free member
Vuoi leggere questo articolo e le altre notizie e approfondimenti su Ninja? Allora registrati e diventa un membro free. Riceverai Breaking News, Marketing Insight, Podcast, Tips&Tricks e tanto altro. Che aspetti? Tieniti aggiornato con Ninja.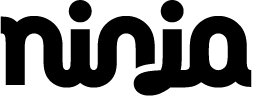
Diventa free member
Vuoi leggere questo articolo, le altre notizie e approfondimenti su Ninja? Allora lascia semplicemente nome e mail e diventa un membro free. Riceverai Breaking News, Marketing Insight, Podcast, Tips&Tricks e tanto altro. Che aspetti? Tieniti aggiornato con Ninja.
Questo articolo nasce dalle parole innocenti di una mia collega, una ragazza di 24 anni molto brava e sveglia nonché totalmente, pienamente, profondamente millennial. Nei modi, nei gesti, nelle parole. Un giorno, mentre eravamo a mangiare in un buon posto a Milano - concessione degli ultimi giorni di lavoro pre-festivi ;-) - inquadrando un piatto con lo smartphone ha pronunciato queste parole:
"ci faccio una story".
In quel preciso istante, mi sono bloccato e ho iniziato a pensare. Dai pensieri al pezzo, il passo è stato relativamente breve.
Oggi, le social stories sono ovunque: Facebook, Instagram, Snapchat, e chi più ne ha, più ne metta (hai detto Steller?). Tutti a creare storie, a diventare (a detta degli stessi Facebook, Google, Twitter, ...) creatori di storie.
Ma di cosa parliamo, nel 99,9% dei casi? Di una sequenza più o meno piacevole di frammenti di contenuto digitale visual o testuale, tenuti insieme da un collante invisibile e magari da una buona colonna sonora, rigorosamente royalty-free (che quindi, per definizione, tanto buona il più delle volte non è).
Ma le Storie sono tutt'altro.
Questi contenuti prodotti e etichettati sintatticamente come storie sono in realtà patchwork, puzzle, mappazzoni (per dirla alla Barbieri) di atomi sociali, che nulla hanno a che vedere con le storie e con una corretta applicazione dello Storytelling. Certo, per Facebook & co. chiamarle patchwork o mappazzoni sarebbe stato molto meno cool e sexy. Sai quanti utenti attivi in meno? Meglio chiamarle storie, qualunque cosa siano realmente.
Il problema, a mio personale avviso, è che il passo dal sintattico al semantico è brevissimo. Ovvero, con tutta la buona volontà e l'innocenza che la contraddistingue, la mia collega - che ho preso come semplice esempio! - pensava davvero di essere nel bel mezzo della creazione di una storia. Ovvero, pensava di stare applicando le giuste regole e la sana dose di creatività e follia indispensabili a tutti gli story creators. Il risultato del suo sforzo? Qualche immagine e frammento video in sequenza, qualche tag scritto quà e là con colori e font casuali ("sta meglio questo o quello?") et voilà, un contenuto del tutto identico a tanti altri della sua specie. E per di più effimero!
Diverse generazioni sono state e sono tutt'ora abituate a pensare alle storie ripercorrendo le gesta di Cappuccetto, o del Signore degli Anelli, o di Cenerentola, e così via. Storie con la S maiuscola, scritte con un mix pazzesco di idee e tecnica, destinate a durare nel tempo diventando capisaldi della cultura popolare e non (se pensiamo alle tante pubblicità dei brand del lusso che ne hanno fatto tesoro per i loro raffinati esercizi retorici).
Oggi è invece imperante un concetto di storia totalmente impoverito nella sostanza, ed effimero. In una grafica simpatica, il futurologo Brian Solis ha provato ad abbozzare alcuni lavori improbabili (fin lì...) del futuro, proponendo tra gli altri l'Ephemeral Historian. Pensa che delirio insegnare Storia tra qualche anno, alle Elementari così come alle Superiori o all'Università. Ciò, appunto, perché il concetto di storia è stato privato di "pezzi" fondamentali del proprio significato.
Chiunque oggi può 1) creare una storia (o meglio, una "storia") 2) della durata (dunque, della rilevanza) nulla. Forse le due dimensioni vanno a braccetto, e il secondo punto è stato introdotto proprio per liberare la rete da un po' di spazzatura e content caos. Prima la carota, poi il bastone (presentato in modo cool - "che fika la storia temporanea!" "Tutti a screenshottarci a vicenda!" "Azz no aspetta ma ho letto che se screenshotto arriva la notifica al mio amico!").
Un segnale di tale deriva sta nella recente regolamentazione delle attività di blogger e "influencer", i/le quali oggi devono includere l'hashtag #ad per identificare con chiarezza quando un contenuto è promozionale verso un brand o un'azienda. Se leggiamo tale provvedimento dal rovescio della medaglia, capiamo di essere stati per anni di fronte a sedicenti storyteller (tipicamente, è proprio questa la prima parola che si legge nella biografia online di un blogger / "influencer"), che altro non facevano che proporci prodotti e servizi con qualche story e scegliendo i giusti filtrini.
Le Storie di Marca sono altre: se ben fatte, non serve nemmeno citare il brand. Hai presente Carosello? Fallo rifare a un blogger ;-)
Il problema di tutto questo, sempre a mio avviso, sta alla base. Ovvero, nel concetto di neutralità dei media digitali.
Tali canali / asset sono certamente spazi da "riempire" e utilizzare come meglio si crede. Ma nessuno ci ha proposto - o addirittura insegnato - come farlo.
Quando impariamo a guidare, prima di metterci in strada facciamo n corse insieme a un co-pilota esperto ed agli amici / parenti. Quando compriamo un tostapane leggiamo prima le istruzioni, in modo da non fare danni. Perfino un prodotto semplice come quello dell'IKEA ha un libretto delle istruzioni lungo e noioso, che però porta alla perfezione relativa - ovvero, al suo corretto assemblaggio.
Perché questo non accade con i media digitali, creando così le premesse per loro utilizzi non consoni (ma ampiamente diffusi)? In sostanza, perché i Big del digitale non si sono preoccupati di fornire prima le istruzioni per l'uso - in questo caso su come si creano delle vere storie - a tutti? Sarebbe stato un gesto pazzesco, virtuoso e capace di fare bene all'intera umanità, elevandola. Se ti interessa questo concetto, consiglio di leggere un mio recente LinkedIn Pulse dal titolo significativo: "Semplice non Significa Banale".
Al contrario, l'esempio delle storie ci insegna che siamo in un nuovo clima di digital divide. Non più legato all'accesso alle infrastrutture IT, ma interno allo stesso ambiente digitale. Usiamo male gli strumenti che abbiamo a disposizione, perdendoci tempo e generando al contempo l'auto-consapevolezza viziosa di essere degli ottimi storyteller. #Maddeché
Pensiamoci insieme: forse non è un caso che i grandi imprenditori digitali si impegnino sempre più in dispendiose attività / iniziative di Corporate Social Responsibility. La coscienza un po' sporca dovranno pure averla, e non per avere compiuto qualche fatto fisico grave: piuttosto, per stare facendo degenerare la situazione attraverso la creazione di eserciti-zombie composti da:
E l'elenco potrebbe continuare all'infinito, se solo avessimo tempo.
Viviamo in un'epoca interessante, ma dobbiamo cercare e dotarci degli strumenti per leggerla dalla giusta prospettiva senza perdere tempo, denaro, risorse cognitive. Il digital detox / digital decluttering non basta e ha il più delle volte un approccio difensivo / reattivo: bisogna capire proattivamente come maneggiare i media digitali al meglio.
La sfida etica ed educativa è aperta, e a mio avviso caratterizzerà il 2018 sia lato utenti, che piattaforme.
Le social stories sono sulla bocca di tutti, e sono un pericolo importante.